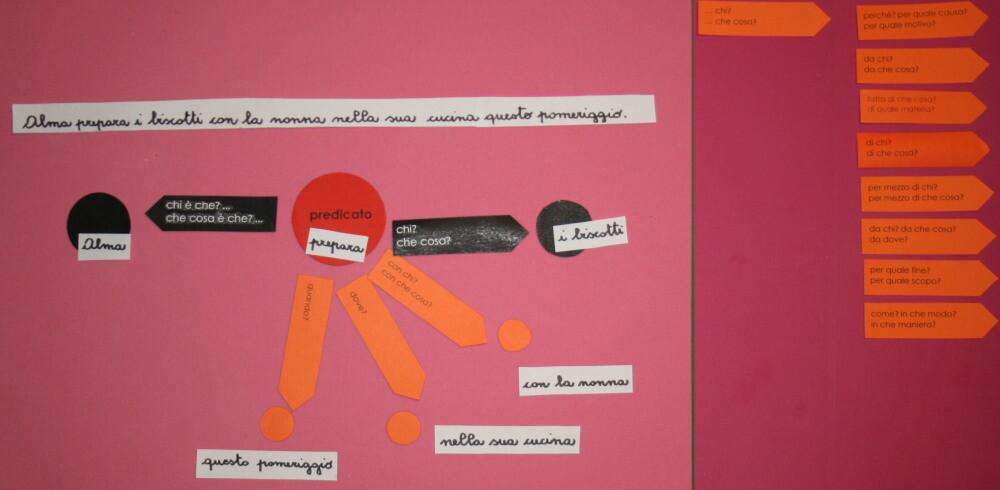I complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– strisce di carta bianca– penna nera dalla scatola […]
Leggi tuttoCategoria: analisi del periodo Montessori
ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori
ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori, per conoscere i complementi indiretti e analizzare la frase semplice e complessa. Scatola C1a per l’analisi […]
Leggi tutto- analisi del periodo Montessori
- analisi logica Montessori
- classe 1a
- classe 2a
- classe 3a
- classe 4a
- classe 5a
- dai 6 anni
- DOWNLOAD
- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI
- italiano
- LINGUAGGIO MONTESSORI
- materiale didattico
- nomenclature Montessori
- psicogrammatica Montessori
- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'
- TUTTI GLI ARTICOLI
L’analisi della proposizione e del periodo col metodo Montessori
L’analisi delle proposizione e del periodo col metodo Montessori si realizza con materiali che seguono lo stesso principio dei casellari usati per l’analisi grammaticale. Nelle presentazioni […]
Leggi tuttoGioco della fattoria Montessori
Gioco della fattoria Montessori: la mia versione stampabile completa di tutti gli elementi (attrezzi, personaggi, animali, elementi architettonici,…) e dei cartellini per gli esercizi coi simboli grammaticali.
Leggi tutto- analisi del periodo Montessori
- analisi grammaticale Montessori
- analisi logica Montessori
- cartamodelli
- classe 1a
- classe 2a
- classe 3a
- costruire i materiali Montessori
- dai 3 ai 6 anni
- dai 6 anni
- disegni da colorare
- DOWNLOAD
- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI
- italiano
- lettura e scrittura Montessori
- LINGUAGGIO MONTESSORI
- materiale didattico
- nomenclature Montessori
- psicogrammatica Montessori
- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'
- TUTTI GLI ARTICOLI
Album Montessori per l’area linguistica 6-9 anni
Pubblico qui l’elenco dei post pubblicati ed in fase di pubblicazione che compongono la guida didattica Montessori per l’area linguistica dai 6 anni. Gli articoli pubblicati giorno per giorno saranno aggiornati col relativo link.
Leggi tutto- analisi del periodo Montessori
- analisi grammaticale Montessori
- analisi logica Montessori
- classe 1a
- classe 2a
- classe 3a
- classe 4a
- classe 5a
- classi medie
- dai 6 anni
- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI
- lettura e scrittura Montessori
- LINGUAGGIO MONTESSORI
- psicogrammatica Montessori
- studio delle parole Montessori
- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'
- TUTTI GLI ARTICOLI
Il programma di insegnamento della lingua nella scuola primaria
Il programma di insegnamento della lingua nella scuola primaria Montessori. Lo studio della lingua nella scuola primaria comprende: storia della scrittura e del linguaggio orale (quarta grande lezione), grammatica e sintassi, composizione scritta, linguaggio parlato, letteratura, attività di ricerca.
Leggi tutto- analisi del periodo Montessori
- analisi grammaticale Montessori
- analisi logica Montessori
- dai 3 ai 6 anni
- dai 6 anni
- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI
- lettura e scrittura Montessori
- LINGUAGGIO MONTESSORI
- psicogrammatica Montessori
- studio delle parole Montessori
- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'
- TUTTI GLI ARTICOLI
Perchè si insegna la grammatica?
Perché si insegna la grammatica? L’obiettivo dello studio della grammatica, nella scuola primaria, è quello di arricchire il linguaggio del bambino, sviluppare l’arte della comunicazione e stimolare il suo interesse verso la lingua, per soddisfare il suo bisogno di inserirsi in modo sempre più pieno nella società. Lo studio della grammatica lo aiuta a prendere coscienza degli aspetti della lingua che già conosce, in particolare l’ordine, la struttura e la composizione .
Leggi tutto