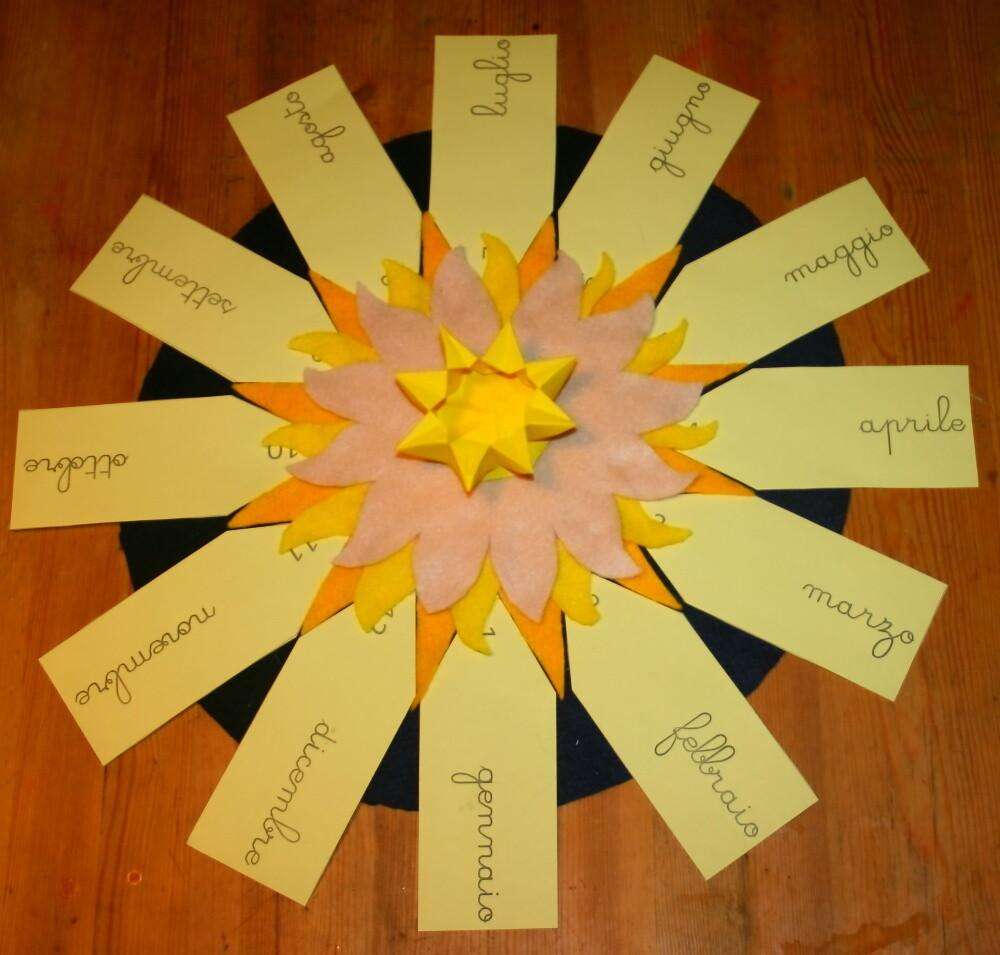Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]
Leggi tuttoCategoria: STORIA
Storia delle armi dalla clava a oggi
La storia delle armi per bambini della primaria con testi e immagini che possono essere d’aiuto per preparare carte delle nomenclature, linee del tempo ed […]
Leggi tuttoGuest tutorial preistorico – Idee per una sensory tub
…idee per realizzare delle sensory tubs preistoriche che, seguendo i corretti principi scientifici, riproducono uno scavo archeologico in forma di gioco didattico…
Leggi tutto