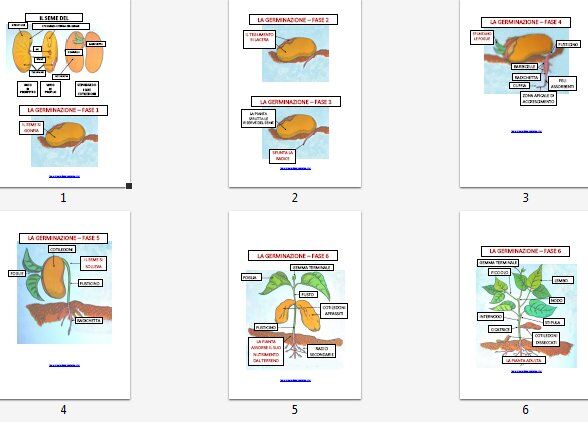FRAZIONI esercizi per la quarta classe della scuola primaria, stampabili e scaricabili gratuitamente in formato pdf.
Leggi tuttoCategoria: classe 4a
NUMERI CARDINALI E ORDINALI esercizi per la quarta classe
NUMERI CARDINALI E ORDINALI esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.
Leggi tuttoESERCIZI DI MATEMATICA per la quarta classe
ESERCIZI DI MATEMATICA per la quarta classe di riepilogo ad inizio anno scolastico, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.
Leggi tuttoFRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta
FRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf
Leggi tuttoIL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta
IL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta della scuola primaria scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.
Leggi tuttoIL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE
IL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE Una raccolta di esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.
Leggi tuttoFENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico
FENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico di autori vari, per bambini della scuola primaria.
Leggi tuttoVULCANI materiale didattico vario
VULCANI materiale didattico vario
Leggi tuttoIL NOME esercizi per la quarta classe
IL NOME esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.
Leggi tuttoSCOPERTA DELL’AMERICA materiale didattico vario
SCOPERTA DELL’AMERICA materiale didattico vario per la scuola primaria: dettati, letture, racconti, poesie e filastrocche sul tema.
Leggi tuttoLA GERMINAZIONE tavole e schede
LA GERMINAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoIL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede
IL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoPARTI DELLA PIANTA tavole
PARTI DELLA PIANTA tavole pronte per la stampa e il download gratuito, in formato pdf, per bambini della scuola primaria.
Leggi tuttoFUNGHI tavole riassuntive e schede
FUNGHI tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoALGHE tavole riassuntive e schede
ALGHE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoMUSCHIO tavole riassuntive e schede
MUSCHIO tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoFELCI tavole riassuntive e schede
FELCI tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoGRAMINACEE tavole riassuntive e schede
GRAMINACEE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoLE LILIACEE tavole riassuntive e schede
LE LILIACEE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoALBERI FORESTALI tavole riassuntive e schede
ALBERI FORESTALI tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoLE SOLANACEE tavole riassuntive e schede
LE SOLANACEE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito, in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoLE COMPOSTE tavole riassuntive e schede
LE COMPOSTE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoLE OMBRELLIFERE tavole riassuntive e schede
LE OMBRELLIFERE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoLE ROSACEE tavola riassuntiva e schede
LE ROSACEE tavola riassuntiva e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoLE CROCIFERE tavola riassuntiva e schede
LE CROCIFERE tavola riassuntiva e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoLA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE scheda riassuntiva
LA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE scheda riassuntiva pronta per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.
Leggi tuttoITALIA materiale didattico
ITALIA materiale didattico – una raccolta di materiale didattico vario per iniziare lo studio della geografia italiana nella scuola primaria.
Leggi tuttoMateriale didattico sui minerali
Materiale didattico sui minerali per la scuola primaria. Il regno minerale. Un sasso, un pezzo di ferro sono corpi senza vita, senza movimento: non respirano, non mangiano, non crescono e non si riproducono.
Leggi tuttoDettati ortografici e materiale didattico sulle PIANTE
Dettati ortografici e materiale didattico sulle PIANTE. Dal fiore al frutto. Tra la nube dei fiori del frutteto le api sono incessantemente all’opera; e se osserviamo un fiore schiuso da qualche ora, sullo stimma verde ed umido non sarà difficile scorgere qualche granulo di polline giallo portato lì da un’ape.
Leggi tuttoMateriale didattico sul FIORE
Materiale didattico sul FIORE per bambini della scuola primaria. I fiori. Il gambo dei fiori si chiama peduncolo. La parte più bella ed appariscente è la corolla, composta da foglioline variamente colorate che si chiamano petali.
Leggi tuttoIl fuoco agli uomini – LEGGENDA SARDA
Il fuoco agli uomini – LEGGENDA SARDA per bambini della scuola primaria.
Leggi tuttoAnfimonio ed Anapia LEGGENDA DELLA SICILIA
Anfimonio ed Anapia LEGGENDA DELLA SICILIA
Leggi tuttoOrigine dello Stromboli LEGGENDA CALABRESE
Origine dello Stromboli LEGGENDA CALABRESE
Leggi tuttoIL PESCATORE DI TRANI Leggenda pugliese
IL PESCATORE DI TRANI Leggenda pugliese
Leggi tuttoRonca Battista LEGGENDA DELLA BASILICATA
Ronca Battista LEGGENDA DELLA BASILICATA
Leggi tuttoPaolaccio LEGGENDA DEL MOLISE
Paolaccio LEGGENDA DEL MOLISE
Leggi tuttoIl mostro del mare LEGGENDA ABRUZZESE
Il mostro del mare LEGGENDA ABRUZZESE per bambini della scuola primaria.
Leggi tuttoIl miracolo di San Catello LEGGENDA DELLA CAMPANIA
Il miracolo di San Catello LEGGENDA DELLA CAMPANIA per bambini della scuola primaria.
Leggi tuttoLa lampada che non si spegne – leggenda del Lazio
La lampada che non si spegne – leggenda del Lazio per bambini della scuola primaria.
Leggi tuttoIL DRAGO DI TERNI leggenda umbra
IL DRAGO DI TERNI leggenda umbra, per bambini della scuola primaria.
Leggi tutto